![]()
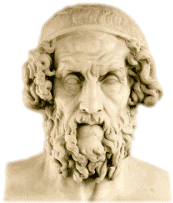 Purtroppo
poco si sa sulla biografia di Omero, si pensa sia vissuto in Grecia tra l'VIII ed il VII sec. a.C.
nella Ionia, probabilmente nella città di Smirne, ma nulla si ipotizza sulla
sua morte. Le uniche cose su cui gli esperti si dichiarano certi è che fosse
cieco, povero e che svolgesse la professione di "aedo", cioè cantore itinerante di storie epiche nelle corti della Grecia.
Forse, è l'autore dell'Iliade e dell'Odissea, che narrano la leggendaria guerra di Troia e le vicissitudini del ritorno in patria dell'eroe greco Ulisse, Odisseo.
Ma già nel III sec. a.C. i grammatici mettevano in dubbio che tali opere fossero
sue; prevalse però l’opinione di Aristarco secondo il quale l’Iliade era stata composta in gioventù, mentre l’Odissea nella maturità. In questo modo Aristarco cercava di spiegare la diversità di struttura tra i due poemi e riconosceva che, forse, alcuni versi o addirittura parti di altri poeti erano finiti nei poemi.
Quest’opinione fu accettata fino al sec. XVIII. Poi, in Francia, in Italia e nel 1795 da
Wolf, si fece strada l’idea che Omero non fosse proprio esistito e che le opere a lui attribuite fossero, in verità, raccolte di canti di vari poeti.
Purtroppo
poco si sa sulla biografia di Omero, si pensa sia vissuto in Grecia tra l'VIII ed il VII sec. a.C.
nella Ionia, probabilmente nella città di Smirne, ma nulla si ipotizza sulla
sua morte. Le uniche cose su cui gli esperti si dichiarano certi è che fosse
cieco, povero e che svolgesse la professione di "aedo", cioè cantore itinerante di storie epiche nelle corti della Grecia.
Forse, è l'autore dell'Iliade e dell'Odissea, che narrano la leggendaria guerra di Troia e le vicissitudini del ritorno in patria dell'eroe greco Ulisse, Odisseo.
Ma già nel III sec. a.C. i grammatici mettevano in dubbio che tali opere fossero
sue; prevalse però l’opinione di Aristarco secondo il quale l’Iliade era stata composta in gioventù, mentre l’Odissea nella maturità. In questo modo Aristarco cercava di spiegare la diversità di struttura tra i due poemi e riconosceva che, forse, alcuni versi o addirittura parti di altri poeti erano finiti nei poemi.
Quest’opinione fu accettata fino al sec. XVIII. Poi, in Francia, in Italia e nel 1795 da
Wolf, si fece strada l’idea che Omero non fosse proprio esistito e che le opere a lui attribuite fossero, in verità, raccolte di canti di vari poeti.
La "questione omerica" è ancora aperta!
![]()
Note biografiche a cura di Maria Agostinelli
Nel V sec. a.C venne scritta una biografia, attribuita ad Erodoto, nella quale si racconta una romanzesca storia di un poeta cieco errante per le città del mediterraneo. I casi narrati in questa biografia sono evidentemente inventati e rivelano lo sforzo di delineare una vera e propria trama da romanzo. Quindi il tentativo di gettare un pò di luce sulla personalità di Omero appare impossibile. Lo studio critico dei poemi Omerici ebbe inizio nel VI sec. a.C. e si sviluppò poi nell'età ellenistica. Teagene di Reggio cercò in essi significati morali ed allegorici; Senofonte, Platone ed Aristotele ne descrissero il significato generale; Antimaco si occupò della divisione delle varie parti. Aristarco, seguito da Zenodoto e da altri, studiò attentamente il testo nella sua struttura, suggerendo numerosi emendamenti. La fortuna dell'Iliade e dell'Odissea fu nel mondo antico enorme. I due poemi divennero i testi più letti della società greca e poi di quella romana: erano studiati nelle scuole, recitati in mille occasioni e imitati in ogni modo. Nessuno dei critici mise mai in dubbio l'identità di Omero; Zenone ed Ellanico si posero il problema della possibilità che entrambi i poemi fossero attribuibili allo stesso autore, concludendo che fosse impensabile l'esistenza nello stesso periodo di due grandi autori con caratteristiche così simili. Le differenze tra le due opere sono state attribuite alle diverse impostazioni dei due poemi: l'Iliade è un poema di guerra mentre l'Odissea è un poema di pace. Era opinione diffusa nella erudizione antica che il processo di codificazione e di fissazione per iscritto dei poemi omerici fosse avvenuto in Atene nel VI sec. a.C. per opera di Pisistrato. La notizia più antica, relativa a questa tradizione, è di Cicerone, ripetuta poi in varie forme da Pausania, da Eliamo, da Libanio e dagli scolastici, variamente arricchita in modo fantasioso. Anche per l'erudizione antica il punto di partenza erano le contraddizioni logiche e cronologiche presenti nei due poemi; nonchè la mancanza assoluta di opere scritte prima di Omero. Altro argomento di discussione era il contrasto esistente tra il quinto e il tredicesimo canto dell'Iliade: nel quinto il re dei Paflagoni è ucciso da Menelao, nel tredicesimo piange il figlio morto in battaglia. Altra contraddizione è rappresentata dal decimo libro dell'Iliade, il canto della ferina impresa notturna di Odisseo e Diomede, che catturano e massacrano Dolone. Un canto la cui assenza non disturberebbe il flusso del racconto, anzi comporta dei contrasti notevoli: come la prosecuzione naturale della notte, con due consigli notturni e tre cene di Odisseo. Si sono, dunque, venute affermando già nella critica antica le teorie principalmente miranti a dar conto dell'origine dell'epos omerico, più volte riprese e rielaborate nelle età successive. Due sono gli atteggiamenti principali: quello "analitico" (i "Korizontes" attribuivano l'Iliade e l'Odissea a due poeti diversi, i critici che dichiaravano estranea all'Iliade la "Dolomia") e quello "unitario" che cerca di liberarsi dalle contraddizioni considerando inautentici singoli versi. Anche i due poli tra cui oscilla la discussione moderna, "oralità" e "scrittura", sono già presenti tra le soluzioni che gli antichi tentavano di dare al problema omerico. La visione di Giuseppe Flavio, vissuto nell'età dei Flavi, è quella di una composizione orale dei poemi e di una loro tradizione a lungo affidata alla memoria; infine, di una loro redazione scritta molto tarda. Altra ipotesi è quella della dispersione dei poemi a causa di una catastrofe naturale, che presuppone appunto una originaria redazione scritta. Il primo vero teorico moderno dell'ipotesi "oralista" fu Vico, che affermò l'inesistenza della scrittura nella Grecia di Omero e quindi la stesura scritta delle opere nei secoli successivi, da qui l'affermazione della impossibilità dell'esistenza di un Omero-persona concepito solo come Omero-idea. L'esperimento di Wilman Pazzy, che ricorse all'epica orale jugoslava per comprendere la genesi e la struttura dell'epos omerico, partiva da premesse affini a queste. Vico dimostra una certa oscillazione tra la totale negazione dell'individualità di Omero e l'ammissione di una sua parziale storicità. Le riflessioni di Vico sono rimaste per lungo tempo sconosciute, l'unico a capirne il valore fu Wolf, che nei suoi scritti diede l'avvio alla riflessione "analità" dell'ottocento. Per Wolf all'origine degli attuali poemi vi sono canti separati, brevi unità minori, di età e di autori diversi, concepiti prima della diffusione della scrittura e cantati dai rapsodi. Herder reagì alla teoria redazionale di Wolf ribadendo che i due poemi non potevano considerarsi mera raccolta redazionale, poichè sono opera poetica. Nei decenni seguenti la riflessione si concentrò soprattutto sul dilemma unità, ovvero molteplicità, e quindi stratificazione. Si affermarono nuove teorie: quella di Gottfried Hermann, quella di Karl Lachamann, quella di Kirchleoff. Dal 1870 iniziarono le scoperte archeologiche: di Schliamann, che identificava le distruzioni e le ricostruzioni di Troia nei siti nominati da Omero; di Evans, che ritrovava a Creta i resti di una civiltà elevata molto simile a quella degli "Achei" di Omero. La discussione tra "analitici" e "unitari" si protrasse nell'ottocento risentendo del clima culturale del periodo: nel positivismo prevalse la frantumazione analitica, nel clima di ritornante idealismo si accreditò la tendenza unitaria. Le due posizioni, erano e rimanevano sostanzialmente incompatibili. Il problema trovò una situazione accettabile nelle tesi di Parry, il quale era partito dalla preponderante formulità del linguaggio epico: il sistema delle formule veniva considerato come una grammatica la cui unità di base è costituita appunto dalle formule, che ritornano spesso sempre uguali. Questo valorizza la tesi che i poemi siano stati tramandati oralmente e, solo in seguito, riportati per iscritto, ciò è stato provato empiricamente da Parry che registrò la recitazione di un poema amplio quanto Odissea da parte di un cantore serbo analfabeta. Certo è verosimile che per almeno un paio di secoli i rapsodi che hanno tramandato i poemi omerici abbiano fatto ricorso alle tecniche compositive della tradizione orale, è possibile arguire che alle loro spalle ci fosse stata un'epica scritta. Ma il problema omerico non può dirsi risolto neppure con la scoperta della formularità e della convenzionalità dello stile epico e della presenza incisiva della tradizione aedica orale anche nei poemi omerici. Divide ancora gli studiosi il problema del ruolo esercitato nell'epos omerico dall'improvvisazione. Associata a questo contrasto di valutazione è il problema legato all'alfabetizzazione di Omero. Secondo alcuni omeridi fu lo stesso poeta dell'Iliade a comporre per primo il nuovo epos valendosi dell'arte della scrittura. A questa ipotesi si affianca quella di un cantore-compositore illetterato che avrebbe dettato per intero il testo del poema ad uno scriba verso la fine del sec. VIII. Altri pensano ad una trascrizione di singole parti dell'epos nel sec. VII, gli eredi del Parry pensano ad una stabilizzazione orale fino al sec. VI. La trasmissione del testo omerico continuò ad essere orale anche dopo le prime registrazioni scritte del tardo sec. VI. Questa assoluta supremazia della poesia omerica fu assicurata da una parte da una potenza immaginativa e da un vigore poetico, tali da fare di Omero l'archetipo di tutta la poesia greca, dall'altra, dal fatto che i due poemi per la loro eccellenza furono adottati per secoli interi come esempio di ideologia, come enciclopedia tribale che esamina la funzione sociale ed educativa della poesia greca. Anche oggi, a chi voglia interessarsi della civiltà ellenica, si impone l'obbligo irrinunciabile di accostarsi intelligentemente al testo dei poemi omerici, perchè in essi risiede "la ragione d'essere e la giustificazione finale della questione omerica". Omero apre ed esaurisce in sè il periodo propriamente detto che si presenta poco chiaro, ma la lettura di queste opere mette in luce la grandezza e lo splendore degli inizi della letteratura greca.
Tutto ciò che si sa di Omero è leggenda. Incerto è il suo luogo di nascita: probabilmente la città di Chio, o quella di Colofone, oppure Smirne, per anni la più quotata per motivi linguistici e culturali. Incerta è l'origine del suo nome, forse di etimologia non greca: potrebbe derivare da ho mè horôn, ossia 'il non veggente' (la leggenda ci descrive infatti Omero come un aedo cieco), ma altri avanzano l'ipotesi che il suo significato sia quello di 'ostaggio' oppure di 'raccoglitore'.
Per quanto riguarda l'età in cui visse (e quindi l'epoca dell'Iliade e dell'Odissea), le date oscillano tra il XII e il VI secolo A.C., anche se le tesi più accreditate propendono per il VII o VIII secolo. Per Erodoto, invece, Omero sarebbe vissuto 4 secoli prima di lui, il che collocherebbe l'aedo indietro nel IX secolo. La maggior parte delle sue tarde (e fantasiose) biografie sono zeppe di notizie senza alcuna possibile corrispondenza con la realtà, come ad esempio l'aneddoto relativo alla sua gara poetica con Esiodo.
Ad Omero, considerato il primo poeta epico, gli antichi attribuirono molte opere: oltre all'Iliade e all'Odissea egli avrebbe composto dei poemi ciclici (Tebaide, Epigoni, Ciprie ecc.), una raccolta di inni, alcuni epigrammi e dei poemetti di genere giocoso. A nessuno venne in mente che Omero potesse non essere mai esistito finché, nel III secolo A.C., Zenodoto non sollevò dei dubbi circa la paternità di alcuni versi dell'Iliade e dell'Odissea, presto seguito da Ellanico e Xenone i quali, insospettiti dall'apparente disomogeneità linguistica ed ambientale che correva tra i due poemi, ipotizzarono che il secondo fosse stato composto da un ignoto aedo ben 100 anni dopo il primo.
Era l'inizio dei dibattiti e delle ricerche sulla cosiddetta 'questione omerica', riguardante soprattutto la vera paternità dei due poemi epici a noi pervenuti, ma allargata anche ad altri quesiti, quali: Omero è esistito davvero? I due poemi fanno parte di un tutt'uno omogeneo? E se appartengono a più autori in che modo sono stati composti e tramandati? Già Aristarco di Samotracia tentò di dare una spiegazione: l'Iliade e l'Odissea appartengono uno alla giovinezza e l'altro alla vecchiaia dello stesso autore (Omero, naturalmente).
Col passare del tempo, però, le soluzioni non sembrarono più così a portata di mano e le correnti 'unitaria' e 'antiunitaria' (che sostenevano rispettivamente la tesi dell'autore unico e quella della pluralità di autori) si arricchirono delle ipotesi più variegate. G. B. Vico pensava che Omero non fosse mai esistito ma che fosse semplicemente stato assurto a simbolo della poesia greca dell'età eroica, nonostante i due principali poemi di quest'ultima si dovessero a più autori. A sua volta Wolf prospettò l'ipotesi che, in assenza della scrittura e nell'impossibilità di mandare a memoria 2.800 versi, differenti aedi fossero stati latori di diversi canti, riuniti poi in forma di poemi epici nell'epoca di Pisistrato.
A loro si aggiunse una visione 'archeologica' dell'Iliade e dell'Odissea, che vennero concepite come un insieme di stratificazioni attribuibili ad epoche differenti o come ampliamenti da nuclei originari. Con il passare del tempo lo sviluppo delle lettere comparate, della filologia, dello studio della letteratura popolare e degli scavi archeologici (che confermerebbero l'esistenza della scrittura già in epoca micenea), ha dato vita alla corrente cosiddetta 'neounitaria', la quale non nega l'esistenza di originari canti primitivi, ma allo stesso tempo afferma con forza l'unità dei due poemi in quanto composti da un singolo autore, che avrebbe raccolto i nuclei originari e li avrebbe ordinati in maniera personale utilizzando il dialetto ionico ed il verso esametro, vale a dire la lingua e la metrica dell'Iliade e dell'Odissea.
A questa corrente si aggiunge l'interpretazione dell'Iliade e dell'Odissea come 'enciclopedie tecnologiche', ossia come collezione di saperi e di pratiche oralmente tramandate, indispensabili alla coesione culturale. Al di là di tutte le possibili versioni, è quasi certo che Omero non sia mai esistito e che i due poemi siano stati tramandati da più aedi erranti.
Ma, nonostante l'autore dell'Iliade e dell'Odissea si riduca ad un fantasma, rimane il mistero di una costruzione e di una sintesi che, probabilmente nel VI secolo, ordinarono la materia informe ed eterogenea dei racconti più antichi e ci tramandarono due opere dalla fortuna e dalla forza inestinguibili tra i greci come tra i romani (il primo a tradurre l'Odissea in metro saturnio fu Livio Andronico ed Ennio sostenne addirittura di essere la reincarnazione di Omero), passando per il Medioevo (tramite l'Omero latino) e per l'Umanesimo, su su fino ai giorni nostri, offrendo a chiunque voglia leggerle due storie rimaste miticamente e straordinariamente avvincenti.
![]()